ISTITUTO PROFESSIONALE "E.VANONI" DI RIETI
una scuola..... in movimento
Via degli Olmi s.n.c. 02100 Rieti Tel.0746 271981-Fax 271993
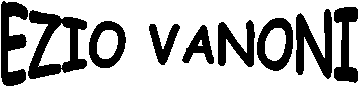

Primogenito di quattro figli, nacque a Morbegno in provincia di Sondrio (Valtellina) il 3 agosto 1903. Cresciuto in un’agiatezza familiare dovuta ai redditi da lavoro del padre (segretario comunale a San Martino Val Masino) e della madre (maestra), trascorse l’infanzia tra Morbegno e San Martino (dove talvolta accompagnava il padre). Luoghi marchiati da una profonda povertà che mai potrà cancellare dai suoi ricordi.
Portò a termine gli studi elementari a Morbegno e quelli liceali a Sondrio, con il rigore di uno studente sempre primo della classe. Si laureò in Giurisprudenza nel 1925 al Collegio Ghislieri di Pavia con Benvenuto Griziotti, discutendo una tesi dal titolo “Natura ed interpretazione delle leggi tributarie”.
Fu proprio negli anni trascorsi al Ghislieri che Vanoni fece le prime esperienze politiche. Spinto da ideali libertari e da un senso di solidarietà, si accostò al Gruppo studenti Socialisti (si contrapponeva ai Gruppi universitari fascisti che nascevano con l’imporsi del fascismo).
Conseguita la laurea, a causa dell’affermarsi totalitario del fascismo che reprimeva qualsiasi forma di opposizione e qualsiasi forma di libera espressione del pensiero, esaurì anche la vocazione politica sbocciata a Pavia, dedicandosi totalmente agli studi e alla carriera.
Divenne subito assistente volontario di Benvenuto Griziotti nell’Istituto Giuridico dell’Università di Pavia, lavorando tra il 1926 e il 1927 ad una ricerca dal titolo “La rivalutazione della lira e l’equilibrio economico” (era una ricerca che rientrava nel dibattito “quota novanta”).
Nel 1926 vinse la borsa di studio Lorenzo Ellero, per due anni di perfezionamento in scienze economiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che però non portò a termine in quanto nel 1928 si vide assegnare una borsa di studio dalla Fondazione Rockefeller, per due anni di studio in Germania.
Nei due anni vissuti in Germania approfondì gli studi in scienza delle finanze e in diritto finanziario, acquisendo un ampio bagaglio scientifico nel ramo finanziario. In quegli anni maturò anche una concezione dello Stato come entità morale prima che politica.
Nel 1930 ebbe l’incarico per l’insegnamento di Scienza delle Finanze e Diritto finanziario nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari. L’anno seguente, aprì a Milano uno studio come avvocato, frequentato da un’importante clientela.
Nel 1932 si vide assegnare l’incarico di libera docenza in scienza delle finanze e diritto finanziario. Nello stesso anno, il 7 gennaio 1932, si sposò a Morbegno con Felicita Dell’Oro, dalla cui unione nacquero Marina (nel 1933) e Lucia (nel 1934). Dal 1932 Vanoni continuò ad inseguire la titolarità della cattedra in scienza delle finanze e diritto finanziario (di cui già possedeva la libera docenza), ma incorse in pesanti bocciature, nel 1932 quando si presentò per la cattedra dell’Università di Messina e nel 1935 allorquando sostenne l’esame per la cattedra dell’Università di Camerino. Probabilmente Vanoni non si vide assegnare la cattedra perché non era iscritto al partito nazionale fascista, circostanza questa che lo relegò in uno stato di emarginazione e che gli precluse, per molti anni, qualsiasi ambizione di carriera.
Dal 1933 al 1936 Vanoni ricevette l’incarico per la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma. Gli anni che visse a Roma furono molto importanti per la sua maturazione ideologica e politica. Conobbe infatti, Sergio Paronetto, la cui amicizia venne facilitata da Pasquale Saraceno, docente all’Università di Roma, dirigente dell’Iri e cognato di Vanoni, e riprese a frequentare i vecchi compagni di lotta del Collegio Ghislieri.
Fu grazie a Paronetto che, a Roma, Vanoni entrò in contatto con esponenti del mondo cattolico quali De Gasperi e Gonella che contribuirono alla rinascita di una vocazione politica che Vanoni aveva accantonato da tempo. Fu sempre Paronetto l’ispiratore della trasformazione di Vanoni da uomo di studio a uomo di azione e che gli fece riscoprire la fede religiosa.
Conclusasi l’esperienza di insegnamento all’Università di Roma, dal 1937 al 1938 Vanoni insegnò su incarico all’Università di Padova (sempre scienza delle finanze e diritto finanziario) e fondò, insieme a Benvenuto Griziotti e Mario Pugliese, la “Rivista di scienza delle finanze e diritto finanziario”. Nel 1938 pubblicò “Il problema della codificazione tributaria”, in cui traspariva con evidenza l’influenza lasciata dagli incontri romani con Paronetto.
Nello stesso anno, per amor di carriera, aderì al partito nazionale fascista anche se subì come una vergogna la tessera che lo qualificava come fascista e non rinnegò mai il suo passato di giovane socialista. Fu così che nel 1939 vinse la titolarità della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, presso l’Istituto Superiore di Economia e Commercio di Venezia, Ca’ Foscari.
Tra il 1941 e il 1944 Vanoni partecipò, insieme a De Gasperi, Paronetto, Capograssi e Saraceno alla stesura del “Codice di Camaldoli”, documento sintetizzato in settantasei enunciati di chiara ispirazione antifascista, in cui si affermava lo Stato come entità morale e la politica come scienza che tendeva alla realizzazione della giustizia sociale, rivolto a tutte le coscienze cattoliche che dovevano reagire alla condizione di torpore ideologico e di azione, in cui il fascismo le aveva trascinate.
Negli anni successivi, al codice vennero aggiunti due capitoli che riguardavano i temi della famiglia e dell’educazione. Argomenti che volutamente nel testo originario, furono trascurati per dare maggiore spazio e risalto al tema della giustizia sociale. Il codice ispirò buona parte dell’attività politica di Vanoni. Dal 1943 iniziò la vera e intensa vita politica di Vanoni. Già nella Dc, fu subito nominato Commissario del dissolto sindacato fascista dei lavoratori del commercio. La nomina, seguita poi dalla firma dell’appello ai lavoratori per la resistenza al fascismo e alle forze tedesche di occupazione, fecero sì che Vanoni, braccato dalla dittatura, vivesse in uno stato di clandestinità fino alla liberazione di Roma (4 giugno 1944). Fu questo il periodo in cui si dedicò maggiormente alla scrittura dei capitoli del Codice di Camaldoli a lui attribuiti.
Dalla liberazione di Roma al 1946 venne investito da numerosi incarichi: commissario alla Banca Nazionale dell’Agricoltura; consigliere nazionale della Dc; deputato per la Dc nell’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946; esperto per le questioni economiche e finanziarie nella delegazione che, presieduta da De Gasperi, partecipò alla Conferenza di pace di Parigi; componente della Commissione dei Settantacinque che fu nominata nel luglio del 1946 per lo studio e la stesura della carta costituzionale.
In particolare, nella Costituente fece parte della seconda commissione (delle tre in cui era stata divisa) che doveva occuparsi dell’ordinamento costituzionale dello Stato e che, fra gli altri problemi, dovette affrontare quello dei poteri da attribuire al Presidente del Consiglio. Vanoni si schierò fra quelli che volevano ampi poteri al Presidente del consiglio, per fare del capo del Governo un vero e proprio primo ministro. Vanoni uscì sconfitto da quella battaglia politica e i poteri assegnati al Presidente del Consiglio furono quelli previsti dall’articolo 95 della Costituzione.
Tra il 1943 e il 1946 pubblicò quattro contributi, espressione del suo pensiero sulla giustizia sociale: “La finanza e la giustizia sociale” (1943); “La persona umana nella pubblica economia” (1945); “Il nostro programma sociale” (1946); “La nostra via” (è il documento che più degli altri, racchiude il suo pensiero in merito al sistema politico ed economico migliore da adottare per realizzare una vera giustizia sociale).
Nel 1947 venne nominato Ministro del Commercio con l’estero, nel terzo Governo De Gasperi. Erano, quelli, anni difficilissimi per l’Italia: inflazione elevatissima; aumento vertiginoso del disavanzo dello Stato; fame dilagante. E la bufera in cui versava L’Italia del ‘47, non risparmiò neppure il Ministro Vanoni, che venne accusato in Parlamento, dal deputato indipendentista Finocchiaro Aprile, di aver percepito compensi esagerati mentre era commissario della Banca Nazionale dell’Agricoltura. La disillusione per le accuse che gli vennero mosse, lo spinsero quasi all’abbandono della vita politica.
La prima esperienza di Governo di Vanoni durò poco più di cento giorni e nel successivo Governo De Gasperi, non occupò alcun incarico di governo. Nelle elezioni del 18 aprile 1948, Vanoni fu eletto Senatore e diventò Ministro delle Finanze, nel rimpasto del Governo deciso da De Gasperi in seguito dell’esito delle elezioni. Vanoni si distinse per la completezza e la lungimiranza delle sue idee in campo economico.
Il filo conduttore, che ha ispirato anche le principali riforme, è la convinzione che è l’economia pubblica che serve l’uomo e non viceversa. In particolare, lo scopo della politica economica è di garantire a tutti gli uomini un’esistenza libera e dignitosa, mantenere la stabilità dell’occupazione assicurando nel contempo a ciascuno un adeguato compenso. Si osserva che, nonostante la matrice socialista del pensiero economico di Vanoni, egli non era un assertore delle teorie keynesiane sull’intervento dello Stato nell’economia. Era profonda convinzione di Vanoni che il perseguimento del fine dell’incremento dell’occupazione e della crescita del reddito nazionale non potrebbe essere conseguito attraverso l’intervento diretto dello Stato per finanziare una politica di lavori pubblici al solo scopo di movimentare il mercato. Infatti, tranne limitate manovre monetarie per ristabilire l’equilibrio tra prezzi interni ed esteri, Vanoni riteneva (con lungimiranza) che il ricorso alla moneta come strumento di politica monetaria indebolisce il sistema monetario, ingenerando dannosi meccanismi inflattivi.
Appena giunto al Governo, iniziò a lavorare alla riforma tributaria prefiggendosi l’obiettivo di raggiungere una giustizia fiscale, che era anche uno dei presupposti di una democrazia autentica. Ma, prima di una riforma in ambito di ordinamento legislativo, era necessaria, innanzitutto, una rivoluzione morale. Bisognava cambiare le coscienze e convincere gli italiani riguardo ai loro obblighi nei confronti del fisco, in virtù di un dovere sociale che era anche un dovere morale.
La legge più significativa della riforma del sistema tributario italiano fu la legge 11 gennaio 1951, n. 25 che passò alla storia con il nome di “perequazione tributaria”. Perequare significava far pagare di più a chi poteva pagare di più per sgravare i meno abbienti.
I cardini della legge erano: l’introduzione della dichiarazione annuale unica dei redditi; l’abbassamento delle aliquote e l’innalzamento dei minimi imponibili; la possibilità che veniva offerta ai contribuenti morosi di condonare il passato senza oneri eccessivi. L’obiettivo era quello di aumentare il gettito delle imposte dirette facendo emergere gli evasori totali che con la nuova legge erano costretti a dichiarare gli incrementi del proprio reddito anno per anno.
La riforma del sistema tributario, però, non poteva prescindere da una radicale riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria. Si diede, quindi, il via al progetto di trasformazione delle strutture che prevedeva interventi sulle sedi, sui mezzi e sugli uomini. Vanoni rivestì la carica di Ministro delle Finanze sino al 12 gennaio 1954. A Vanoni si deve anche la nascita dell’Eni. Difatti, il disegno di legge che prevedeva la costituzione dell’ente, venne preparato dal Ministero delle Finanze quando egli era ministro. La costituzione dell’Eni suscitò molte perplessità e disappunto sia nel mondo politico che in quello imprenditoriale. Si apriva, di fatto, la discussione se fosse più opportuno intervenire in determinati settori dell’economia ritenuti critici con iniziativa privata o con un intervento diretto dello Stato.
Per il caso Eni, il dibattito era se fosse più opportuno intervenire nel settore energetico creando un monopolio privato oppure creando un monopolio pubblico. Vanoni scelse il monopolio pubblico (creando appunto l’Eni), non senza polemiche e aspri dibattiti. La sua scelta di organizzazione produttiva pubblica, era finalizzata a promuovere il bene comune, collegando gli interessi dei produttori con quelli dei consumatori.
Il 18 gennaio 1954 Vanoni fu nominato Ministro del Bilancio nel primo governo Fanfani e mantenne la carica sia nel successivo governo Scelba, sia nel Governo presieduto da Segni.
Durante il suo mandato affrontò il problema cruciale di quegli anni di ripresa economica, ovvero l’espansione dei diversi settori produttivi per lo sviluppo economico del Paese e l’eliminazione della disoccupazione e della sottoccupazione. Presentò, in tal senso, al Paese lo “Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955-64”, che passò alla storia come “piano Vanoni”.
Per un breve periodo, dal 30 gennaio 1956 al 16 febbraio 1956, ricoprì anche la carica di Ministro del Tesoro ad interim.
Alle 14,10 del 16 febbraio 1956, colto da malore mentre pronunciava un lungo discorso al Senato, Ezio Vanoni si spense a Palazzo Madama in presenza della moglie che lo teneva per mano, delle figlie Marina e Lucia e della sorella Giuseppina.
La frase:
“…trovino applicazione le leggi che insieme abbiamo approvato e che abbiamo insieme il dovere di far rispettare da tutti i cittadini” (Ezio Vanoni).